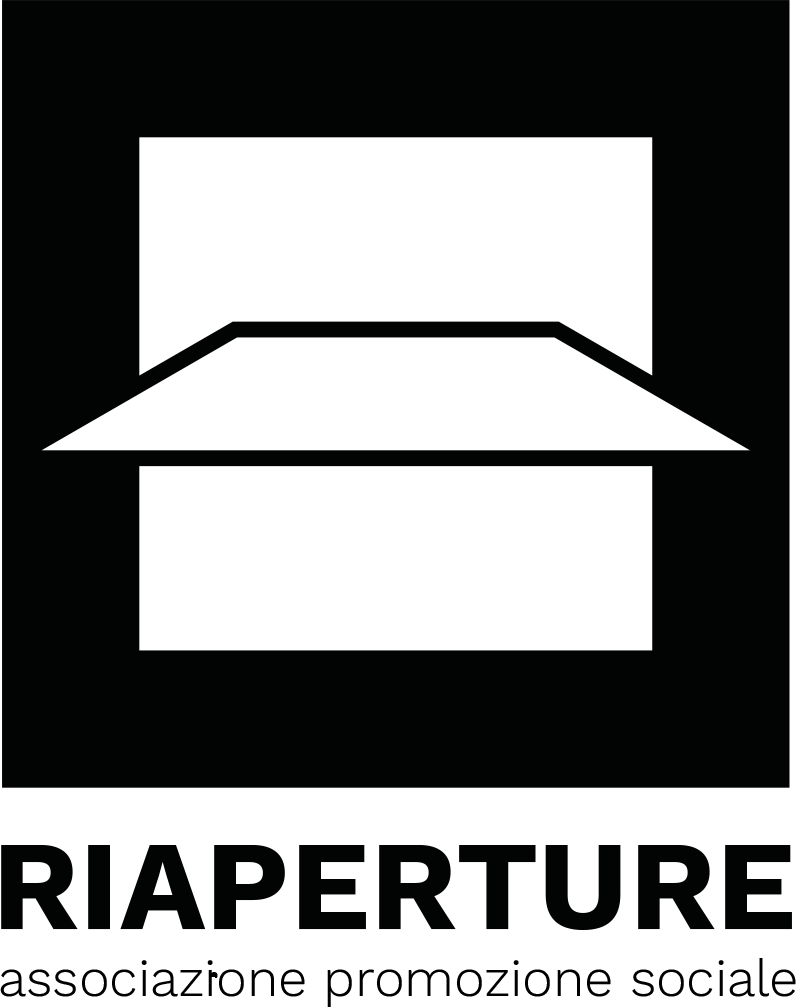Elinor Carucci
Dove
Caserma ‘Pozzuoli del Friuli’
via Cisterna del Follo 10
Ferrara
mappa
Quando
venerdì 29, sabato 30, domenica 31 marzo
venerdì 5, sabato 6, domenica 7 aprile
2019
dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Foto
© Elinor Carucci
Getting Closer, Becoming Mother: About Intimacy and Family.
1993 – 2012
Nel 2004 sono diventata madre.
Emmanuelle, mia figlia, ed Eden, mio figlio, sono nati nell’agosto di quell’anno. Dopo una gravidanza felice, ho avuto un travaglio indotto. Ho subìto un parto cesareo d’emergenza che mi ha lasciata ferita, debole e dolorante. Pochi giorni dopo sono stata rimandata a casa, per cominciare la mia nuova vita come madre di due gemelli. I giorni sono trascorsi, alcuni rapidamente, altri lentamente. Mentre conoscevo i miei bambini, innamorandomi di loro, ho imparato a conoscere meglio anche me stessa. La maternità ha svelato il meglio e il peggio di me. Ero piena di emozioni diverse. La gioia e la meraviglia, l’amore e la felicità coesistevano con la tristezza, la rabbia, la spossatezza e l’ansia. Con un senso di lutto per il corpo che non avrei mai più avuto, per la donna che non sarei mai più stata.
Ho provato e visto così tanto in quei primi mesi: la bellezza e la bruttezza, le lacrime e le risate, i limiti che si arriva a conoscere quando si è un neo-genitore. Ho cercato in qualche modo di affrontare il tutto attraverso la mia macchina fotografica, sperando di rappresentare la complessità della maternità il più onestamente possibile. Troppo intenso, troppo denso, per potersi esprimere solo con immagini sullo stile “Madonna col Bambino”. Non è che non abbia vissuto quei momenti magici e sereni con i miei bambini, e ho scattato anche quel tipo di foto, ma c’era molto di più da raccontare e da mostrare.
Il bisogno di fotografare è diventato ancora più forte quando mi sono resa conto di quanto sia dolorosamente evidente il trascorrere del tempo nella vita di un bambino. Le fasi che attraversano semplicemente volano. Molti momenti che non torneranno più mi sono passati davanti agli occhi e sono facilmente scappati alla mia macchina fotografica: l’ultima volta che ho allattato al seno Emmanuelle, Eden mentre assaggiava le ciliegie per la prima volta, il loro primo litigio. Mi sono sentita in dovere di provare a preservare in qualche maniera questi momenti. È una necessità che ogni genitore, fotografo professionista o meno, avverte: tutti noi scattiamo foto alle nostre famiglie. È come se ci consolassimo con il contare i giorni in questo mondo con i nostri figli.
Fotografare i miei figli è stato diverso da qualsiasi cosa avessi fatto in precedenza. Naturalmente non potevo chiedere loro il permesso di fotografarli, come avevo sempre fatto con altri membri della mia famiglia. Né potevo prendermi il tempo necessario, perché di solito avevo solo pochi secondi per scattare una foto e dovevo scegliere tra fotografare e fare la madre. A volte fare una fotografia è diventato un istante di colpa, perché era un istante nel quale stavo trascurando i bambini. Se pensavo alla luce o alla composizione, anche solo per una frazione di secondo, in quel momento non ero a loro disposizione.
Ci sono voluti alcuni anni perché la fotografa e la madre che sono in me imparassero a coesistere. Le due anime non erano sempre d’accordo: di solito vinceva la madre in me. Ma a volte, con mia grande sorpresa, le mie due identità si rafforzavano a vicenda, soprattutto quando riconoscevo l’effetto positivo che il mio lavoro aveva sui bambini. Erano orgogliosi di essere la mia fonte di ispirazione, del fatto che tutto ciò che li riguardasse – le belle e le brutte giornate, i loro difetti e i loro errori – mi affascinava. Attraverso le mie fotografie ho abbracciato tutti i lati del nostro rapporto, rendendo, per me e per loro, ogni aspetto della nostra vita insieme un argomento legittimo da discutere e fotografare. Recentemente Eden mi ha detto: “Mi arrabbiavo quando mi fotografavi, specialmente quando piangevo, ma ora posso vedere com’ero quando ero arrabbiato, felice o triste. Mentre mi fotografavi, quello era comunque del tempo che potevamo trascorrere insieme”. Emmanuelle condivideva una visione simile: “Anche se prima mi dava fastidio, adesso quando vedo le immagini mi sento bene dentro. A volte mi piacciono e a volte non mi piacciono affatto”. Ho spiegato ai bambini perché faccio spesso delle foto che possono sembrare sgradevoli, ma mia figlia continua a preferire “quelle belle”.
Ho sempre cercato di trasmettere attraverso il mio lavoro una gamma completa di emozioni, di prendere le nostre piccole storie e trasformarle in un epico racconto umano. Sono rincuorata e sollevata nello scoprire quanto la mia storia sia universale, e ringrazio le molte madri che ho incontrato per la loro onestà e disponibilità a condividere le proprie esperienze. Quello che mi hanno detto mi ha resa libera di rappresentare la complessità del rapporto tra madre e figlio, perché molto di quello che ho vissuto è stato vissuto anche da altre donne.
La fotografia non è stata solo un modo per godere dell’amore dei miei figli per me e dimostrare il mio amore incondizionato per loro. Mi ha anche aiutato a risollevarmi nei momenti in cui sentivo di aver fallito come madre o avvertivo del risentimento nei miei confronti da parte loro. A volte, anche solo uno o due scatti mi hanno aiutato a comprendere cosa fosse appena successo e a capire come affrontarlo. C’è un certo potere nella capacità di una fotografia di congelare un momento nel tempo. A volte un’immagine sembrava comprimere il passato e il futuro: potevo vedere i bambini com’erano allora, ma anche come avrebbero potuto essere in seguito. A volte era la mia stessa colpa che fotografavo. Guardare una foto mi ricorda quello che ho sbagliato, ma può anche aiutarmi a perdonare me stessa. Come la maggior parte dei genitori, costantemente mi arrendo e resisto, fallisco e riesco. Con le mie foto spero di dare ai miei figli una carezza che rimarrà con loro anche quando io non ci sarò più. È doloroso sapere che non sarò sempre in grado di proteggerli. Fotografarli è un modo per cercare di affrontare quel dolore. Le mie immagini sono una strategia sia per tenerli con me che per rimanere con loro, per mantenermi vicina.
Niente mi dà ispirazione come guardare i miei figli crescere. La vita di un bambino è così intensa che le attività quotidiane – lavarsi i denti, fare la doccia, un taglio di capelli – diventano momenti teatrali. Una semplice discussione può terminare con le parole “Ti odio! Non sarò mai più tuo amico! Mai più!”. Nel mio lavoro precedente avevo sempre dovuto cercare drammi umani di questo tipo. Ora dovevo solo assicurarmi che ci fosse luce e una macchina fotografica pronta, per non perdere il momento.
Bene o male il processo mi è suonato familiare. La maternità significava mettermi in stand-by, come avevo fatto spesso anche prima con le mie fotografie. Per me l’atto di fotografare ha sempre implicato un’osservazione talmente completa da venire assorbita dal mio soggetto. Ma c’era un limite a questa esperienza: la versione di me presente in quell’arco di tempo sarebbe scomparsa alla fine del servizio. La maternità ha intriso tutta la mia vita di questa modalità di osservazione e assorbimento. Dopo il parto e quelle prime settimane difficili, mi ritrovai (per l’orrore di mio marito) completamente immersa nell’essere la madre dei miei figli. Il che a volte mi spaventava, perché avevo paura che la maternità mi avrebbe sopraffatta, limitata, confinata. Invece è diventata una finestra su molto di ciò che credo sia davvero la vita. Ha distillato l’essenza di tutto, permettendomi di entrare nel rapporto più profondo possibile con un’altra persona e con me stessa, arricchendomi sia come individuo che come artista.
Guardando le immagini degli ultimi anni, ho scoperto di aver portato la mia fotografia per le strade di New York, acquisendo così un nuovo senso di appartenenza all’America, il Paese in cui sono emigrata nel 1995. Come se avessi dato alla luce due radici, i miei figli mi hanno fatta sentire più americana, e per la prima volta ho visto New York come casa. La scuola, il parco giochi, le drogherie e i supermercati: alla fine sono quelli la nostra casa. Il nostro quartiere è il mio piccolo paese. Gli amici dei miei figli sono entrati a far parte del mio lavoro. Ho dovuto lasciare che i miei figli aprissero la strada, diventando io un membro della loro famiglia, non solo rendendoli miei.
Quando ho iniziato questo progetto non sapevo quando questo capitolo della mia vita sarebbe finito. Ho anche temuto la sua fine, sapendo cosa avrebbe significato. Il fulcro del lavoro è il sentimento di unione con i miei figli, un legame così forte che a volte, soprattutto nei primi anni, ho lasciato mio marito Eran fuori dalle immagini. Sono rimasta stupita dalla forte connessione fisica, totale, sensuale, a volte erotica, che ho avuto con i bambini. Una madre con cui ho parlato mi ha detto che ci sentiamo così appagati dai nostri figli, sia fisicamente che emotivamente, che non abbiamo bisogno di altro. “Ma sii paziente. – disse sorridendo a Eran – Lei ritornerà”. E aveva ragione. Eran ha gradualmente trovato la strada per tornare nelle fotografie e nella mia sfera di desiderio. E poi un giorno, nella primavera del 2012, le ho viste: le immagini che mi hanno raccontato che questa fase della mia vita con i miei figli stava giungendo a una svolta.
Quando ero piccola, mia madre mi leggeva brani tratti da Il profeta di Khalil Gibran: “Voi siete gli archi dai quali i vostri figli vengono proiettati in avanti, come frecce viventi”. Ora, madre a mia volta, posso apprezzare il modo in cui lei ci ha preparati a quel momento. Anch’io avevo bisogno di lasciare che i miei figli muovessero i primi passi lontano da me. Era tempo. Il primo capitolo si stava avvicinando alla fine. L’ho dovuto riconoscere, chiamarlo “una serie di immagini” e farne un libro.
Io sono ancora la madre dei miei figli e sempre lo sarò. Li guardo come madre, imparando molto, vedendo così tanto. Fotografarli mi costringe a vedere ancora di più e i bambini mi mostrano di più. Anche quando non sono con me, vedo più del mondo che mi circonda. Non ho mai visto così, come riesco a vedere ora, come una madre.
© Elinor Carucci
Bio
Elinor Carucci (1971, Israele) si è laureata in fotografia all’Accademia delle Arti e del Design di Bezalel nel 1995, per poi trasferirsi a New York nello stesso anno.
Il suo lavoro è stato esposto in numerose mostre personali e collettive in tutto il mondo. Tra le prime figurano quelle presso la Edwynn Houk Gallery, Fifty One Fine Art Gallery, James Hyman, e Gagosian Gallery di Londra. Per quanto riguarda le mostre collettive, citiamo il Museo di Arte Moderna di New York, il MoCP di Chicago e The Photographers’ Gallery a Londra.
Le sue fotografie fanno parte delle collezioni del Museo d’Arte Moderna di New York, del Brooklyn Museum of Art e del Museum of Fine Art di Houston. ll suo lavoro è stato pubblicato su The New York Times Magazine, The New Yorker, Dettagli, New York Magazine, W, Aperture, ARTnews e su molte altre pubblicazioni.
Nel 2001 ha ricevuto il premio ICP Infinity Award, nel 2002 la borsa di studio Guggenheim Fellowship e nel 2010 il NYFA. A oggi Carucci ha pubblicato tre monografie: Closer, (Chronicle Books, 2002), Diary of a Dancer (SteidlMACK, 2005) e Mother (Prestel, 2013).
Attualmente Carucci è docente al corso di laurea in fotografia presso la School of Visual Arts ed è rappresentata dalla Galleria Edwynn Houk.